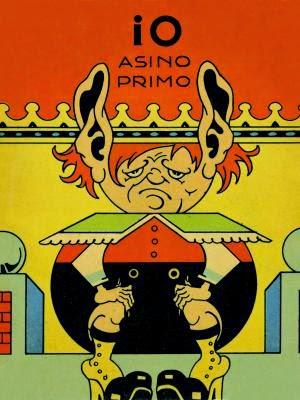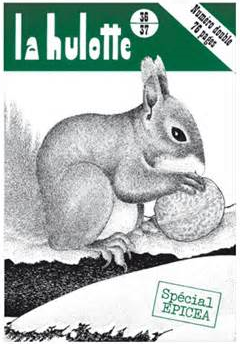1961. Avevo dieci anni. Mia
madre, per un suo qual spirito ugualitario, ci imponeva il doposcuola, di norma
riservato ai poveri e agli orfanelli del Dominioni.
Nel grigio autunno padano, allora
generoso di nebbie fitte e, come sempre, avvezzo a intempestivi tramonti, stare
in quell’aula, mentre scendeva il buio, era qualcosa d’indicibile tristezza.
Ma il maestrino di Barengo, indossava una giacca di velluto nero che lo faceva assomigliare a uno di quei patrioti del Risorgimento, di cui studiavamo le gesta, in quell’anno del centenario, e aveva la faccia allegra, senza contare che asseriva esser amico di Boniperti.
Ci faceva fare dei giochi. Interdetto, per freddo e scarso corredo invernale dei miei compagni, il cortile, dove, in qualsiasi impresa sportiva, quei malnutriti, ma al contempo agili e forti, si sarebbero disputati i premi, lasciandomi buon ultimo, ripiegava sui quiz di cultura generale, dove ovviamente trionfavo, guadagnandomi un’antipatia quasi generale. Passò, quindi, tutto sommato, l’autunno e anche l’ancor più cupo inverno, e venne, infine, la primavera.Reso agibile dai primi tepori, il
cortile restava interdetto per autocratico decreto del Direttore Didattico,
malfido della combriccola di fuorilegge in erba ch’era il nerbo delle unificate
VA e V B del prolungato orario pomeridiano. Ne temeva l’evasione o, peggio, la
propensione al danno alle vetrerie, di cui avevano dato copiose dimostrazioni.
Così, chiesi d’uscire.
Ci doveva essere carenza di
pressione. Dopo aver girato, invano, il rubinetto nel verso giusto, mi provai a
ripetere l’operazione all’inverso. La manopola, in tal modo svitata, mi rimase
in mano.
Fu il panico. Mi figuravo l’ira
dell’irascibile Direttore, immaginavo fatture con sfilze di zeri nelle mani di
mio padre. Lasciai il rubinetto nel lavandino e tornai di corsa in classe,
augurandomi che il patimento della sete, che ora mi pareva stesse varcando i
confini dell’umanamente sopportabile, potesse essere bastevole espiazione della
malefatta.
Dopo di me, chiese d’uscire
Tartarini.
Vittorio, Gerry, Tartarini, in seguito mio buon amico di gioventù, era allora
ospite del Civico Istituto Dominioni, donde sarebbe poi passato – quasi senza
soluzione di continuità – alla più ferrea custodia del minorile Ferrante
Aporti. Ed era un sorvegliato speciale.
Lo spiai al rientro, ma che fosse
uscito per incombenza che gli avesse fatto trascurare i lavandini o che fosse
ormai aduso alla più tenace omertà, nulla notai sull’espressione del suo viso
che potesse denotare agnizione del mio consumato sabotaggio.
Passò del tempo, non potrei dire
quanto, poiché, nel mio stato d’angoscia, ogni minuto sembrava eterno. Poi si
verificò la scena che, fino a quel momento, avevo temuta, immaginata,
anticipata.
La porta si spalancò con
prepotenza. Nel vano si inquadrò per un attimo, fremente di stizza, la sagoma
dello stizzoso Direttore. Poi, questi, con due ampie falcate, s’appropinquò
alla cattedra dell’allarmato maestrino. Con tono brusco, s’informò su chi fosse
uscito dalla classe.
Il maestro, accennò a me: «Veronica
– disse, e indugiò un attimo, poi, come se gli fosse sovvenuto in mente
tardivamente, completò – e Tartarini».
A quel «Veronica», mi si era
raggelato il sangue nelle vene, ma mi ero ormai rassegnato alla mia sorte, e
quasi me ne sentivo sollevato, qualsiasi castigo sembrandomi preferibile all’attesa.
Fui, dunque, colto di sorpresa quando il Direttore, senza la minima esitazione,
voltosi a un Tartarini stupefatto e incredulo, lo invitò, con gesto imperioso,
a seguirlo, e con lui varcò, senza formalità di congedo, l’uscio della classe.
Neanche per un istante, l’equivoco
mi era stato di sollievo, anzi, compresi subito che qualcosa dovevo fare per sventare
quell’orribile errore giudiziario che s’andava profilando, ma quel tempo, che
fino a quel momento sembrava non passare mai, si era messo, ora, a correre all’impazzata.
Cosicché, prima che mi fossi
risolto all’iniziativa, la porta fu nuovamente spalancata, con vieppiù vigore,
per lasciare entrare un Tartarini in lacrime che, subito, si mise a radunare le
sue cose e a riporle nella cartella.
Il maestro, con affettuosa
apprensione cercò d’informarsi, ne vennero fuori poche parole frammiste a
singhiozzi: «... sospeso ... chissà cosa mi faranno in collegio ... gabinetto
allagato ...»
Si seppe poi che, tornata alla
norma la pressione, l’acqua aveva cominciato a fluire da quel rubinetto da me
manomesso e che solo tardivamente il bidello – nighittoso fantasma che
trascorreva le giornate in qualche segreto stambugio, inaccessibile ai più – s’era
accorto della (assai modesta) pozza d’acqua formatasi sul pavimento.
Non aveva ancora finito di dire,
il Tartarini, che già il bidello veniva a informare che uno dei cerberi dell’Istituto
– a un tiro di schioppo dalla scuola – era venuto a prenderlo.
Non indugiai oltre, mentre
Tartarini varcava la soglia, andando incontro al suo destino, mi ero
precipitato dal maestro, rendendo rapida e pubblica confessione delle mie
responsabilità.
Una ruga di preoccupata
attenzione solcò la fronte del mio immaginario mazziniano. «Dobbiamo andare dal
direttore», disse, e a me parve Pisacane che mi proponesse di salpar per Sapri.
E ciò mi rincuorò.
Ero interdetto, ma il maestro, a
scanso di altri colpi di testa, mi afferrò per la spalla e mi spinse a varcare frettolosamente
la soglia.
Finivo la V elementare, avevo appreso,
in qualche modo, a leggere, scrivere e far di conto, ma avevo imparato bene cos’era
il classismo. Quel giorno seppi di essere un comunista.
g.v.
P. S. Rividi per l’ultima volta
Vittorio alla Pavesi, alla fine degli
anni 70, ero operaio di linea e lui era il mio delegato di reparto. Era già
malato e morì ancor giovane.